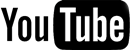Visita didattica per le scuole. Casino Nobile di Villa Torlonia - Approfondimenti: Le origini e l'ascesa della famiglia Torlonia

Casino Nobile
Visita didattica per le scuole.
Casino Nobile: Le origini e l'ascesa della famiglia Torlonia
Il primo esponente dei Torlonia che decise di cercare fortuna a Roma si chiamava Marino: figlio di Antoine Tourlonias, era nato, secondo Gabrielli, in una località chiamata De Puis ed era giunto nella Capitale intorno al 1750, quando aveva 25 anni; pur se approssimativa, la seconda affermazione risponde a verità, la prima, ossia quella relativa al luogo d’origine, molto meno, in quanto nessuna carta della Francia né antica né moderna registra un nome del genere. Esisteva invece Le Puy, villaggio del Puy-de-Dôme sperduto tra i monti dell’Alvernia, nel massiccio centrale, non molto distante da Lione; era esattamente questa la regione in cui era stata attestata la presenza del nonno paterno di Marino, Benoît, che secondo uno storico alverniate era nato a Marat, appunto nel Puy-de-Dôme4. Vedremo subito che la notazione geografica ha un suo peso, dal momento che dopo il trasferimento in Italia e il matrimonio con la romana Maria Angela Lanci5, Marino si dedicò tra le altre cose al commercio dei tessuti. Su come svolgesse i suoi traffici non tutti concordano; ci sembra però abbastanza fantasioso il passo di un lavoro di Domenico Demarco in cui Marino viene descritto come «un rigattiere, che aveva girato per le strade di Roma con un sacco sulle spalle, vendendo abiti usati»6; più clemente, ma anche più vago, Stendhal, che ne aveva conosciuto da vicino gli eredi e lo aveva definito «ex merciaio»7, trovando poi dei seguaci in David Silvagni e in Ugo Pesci che per definire il primo Torlonia stabilitosi a Roma si erano serviti dello stesso sostantivo8; secondo altri, infine, Marino era stato cameriere di un abate ovvero, stando alle più recenti ricerche, del cardinale Acquaviva che morendo gli avrebbe lasciato una «discreta rendita»9: che è qualcosa di diverso dal rigattiere ma, pur non escludendo un primo passaggio come venditore di stracci o di stoffe, fa pensare a un rapporto di lavoro basato sulla fiducia e sulla confidenza, qualcosa di simile a un segretario. In ogni caso perderebbero completamente valore le affermazioni del nostro archivista, secondo il quale il capostipite romano dei Torlonia (non sono riuscito ad appurare la data in cui il cognome fu italianizzato, forse al momento del matrimonio, ma è certo che per i Romani era diventato da tempo “Turloni” o “Turlonia”), «fornito di mezzi paterni aperse un vasto negozio sulla piazza della Trinità dei Monti [Palazzo Zuccari] per lo smercio delle rinomate seterie e broccati di Lione dalle cui ditte veniva direttamente provvisto»10; non escluderei che in quest’ultimo caso questioni di prestigio possano avere consigliato di attribuire al capostipite romano dei Torlonia un mestiere socialmente più qualificante.
Certo, a dare consistenza all’ipotesi di una protezione ben collocata in Curia, c’è il fatto che un rigattiere, per quanto operoso e sveglio, difficilmente sarebbe stato in grado di mettere insieme in meno di un trentennio i capitali che nel 1782 permisero a Marino di aprire un Banco di cambio; cosa che invece sarebbe stata possibile ad un negoziante che fosse stato in condizione di offrire alla società romana più affluente le stoffe preziose importate dalla Francia. Marino, purtroppo, non ebbe il tempo di godersi a lungo le sue fortune, perché la morte lo colse nel 1785, ma chi ne prese il posto, il figlio Giovanni Raimondo, nato a Roma nel 1754, fu colui che veramente fece fare il salto di qualità all’impresa di famiglia11. Intanto egli già nel 1786 affidò il negozio (che prima di morire il padre aveva spostato sulla via Condotti) ad un fiduciario e si dedicò totalmente a consolidare la posizione del Banco, ospitato in alcuni locali di palazzo Raggi: forse in questo lo favorirono i contatti che i Torlonia avevano conservato con il paese di provenienza; certo che molti dei viaggiatori in arrivo a Roma scelsero lui per appoggiare presso il Banco Torlonia il danaro di cui avevano bisogno per i loro lunghi soggiorni. Secondo Gabrielli, lo stesso Giovanni avrebbe ammesso in un abbozzo di autobiografia che nel 1797 era già multimilionario12 (in scudi, s’intende, ossia in una moneta pari a più di cinque volte il franco). Alla base c’erano state senz’altro da un lato la forte disponibilità di liquido datagli dal commercio e dalle somme gestite dal Banco, dall’altro la rete di relazioni in cui egli aveva cominciato a inserirsi attraverso il prestito bancario. Torneremo tra poco su questo punto; per ora introduciamo un altro elemento costitutivo dell’irresistibile ascesa dei Torlonia, che spiega il senso ultimo di tutta questa smania di far soldi, e cioè la voglia di nobilitarsi attraverso una via che non era quella classica del feudo o l’altra del nepotismo papale. Primo passo in questa direzione fu nel 1794 la nomina a barone dell’Impero che gli fu offerta, in cambio dei suoi servigi, dal principe di Fürstenberg, di cui Giovanni era stato agente presso la Santa Sede.
Siamo giunti così ad un nodo storico fondamentale, la crisi di fine Settecento, dal quale emerge tutta la capacità del Torlonia di inserirsi nei movimenti profondi della società per cogliere al volo le occasioni di ulteriore arricchimento. Fino ad ora non abbiamo fatto cenno alla personalità culturale di Giovanni e ai suoi orientamenti politici: della prima, in mancanza di informazioni più precise, possiamo presumere che fosse quella propria delle famiglie romane di condizione economica medio-alta, con una base di tipo umanistico-retorico e con approfondimenti più specifici in materia finanziaria; quanto agli orientamenti politici, riteniamo dovessero essere quelli di un borghese che, non avendo dimenticato le origini francesi dei suoi antenati, era secondo Renzo De Felice uno dei «meno “provinciali”» tra i nobili romani13 e si caratterizzava per una religiosità sincera ma non bigotta che lasciò sui discendenti una sorta di imprinting, tanto che nessuno di essi, pur nella profondità della devozione, si lasciò tentare dall’idea di seguire uno dei percorsi obbligati della nobiltà pontificia, ossia quello dell’aspirazione agli alti gradi del clero14. Tipica di Giovanni fu anche la disponibilità ad aprirsi verso le novità nella misura in cui gliene sarebbe potuto derivare un vantaggio nel campo degli affari. Altrimenti non si spiegherebbero certe disinvolture degli anni della rivoluzione, la più vistosa delle quali pensiamo possa essere quella partecipazione nel gennaio 1793 ad un banchetto offerto dai democratici romani a Bassville che gli attirò la ritorsione degli antifrancesi i quali gli presero a sassate la casa, fornendo all’anonimo cantore di uno dei componimenti del Misogallo romano il destro di scrivere che «dal banchiere Turloni non restò un vetro sano / ché tutto fu sfasciato da una maestra mano»15. A Bassville, come è risaputo, andò molto peggio (ma almeno ebbe la consolazione di essere celebrato dalla penna, ben più ispirata, di Vincenzo Monti).
Va peraltro ricordato che a quel banchetto Torlonia aveva accompagnato la sua futura moglie, Anna Maria Scultheis, una romana trentenne rimasta da poco vedova di Giuseppe Chiaveri dal quale aveva avuto tre figli. Di famiglia ugualmente impegnata in attività bancarie e lei stessa amministratrice di un avviatissimo negozio di coloniali, Anna Maria Scultheis sembra fosse molto legata oltre che a Bassville, dal quale aveva ricevuto pubblicamente in dono una coccarda16, a François-Joseph Digne, console di Francia che rivestiva allora le funzioni di ambasciatore a Roma17. Giovanni la sposò nel 1793 e, a quanto pare, la seguì in alcune sue spericolatezze politiche, la maggiore delle quali, affrontata per motivi che secondo il pettegolo Silvagni avevano molto a che fare con la smania di protagonismo della donna18, fu quella che lo portò ad uno scontro sordo ma dichiarato con il cardinale Ercole Consalvi. La posta in palio era la subordinazione della politica pontificia a quella dell’Impero: prevalsero il denaro e gli interessi francesi, sicché alla fine Consalvi, sconfitto, fu costretto nel 1806 a lasciare la segreteria di Stato. Più tardi avrebbe consegnato alle proprie Memorie solo un velato, anonimo accenno al «gran Finanziere Romano, che mi odiava a morte», un odio – questa la spiegazione del cardinale – che aveva accomunato i coniugi Torlonia e aveva avuto origine nelle «rubberie immense, che almeno nel tempo del mio Ministero non volli mai passar buone al marito e la vanità che non volli lusingar mai della moglie col frequentarla»19.
Le «rubberie» di Giovanni Torlonia avevano rappresentato il premio per chi, come lui, mentre l’aristocrazia romana subiva i colpi della rivoluzione, si era dato molto da fare, cercando sempre di mantenersi fedele al papa (al quale all’occorrenza prestava grosse somme o procurava qualche atteggiamento più rispettoso da parte degli invasori) e al tempo stesso facendo affari con i Francesi. Il momento più propizio fu quello della Repubblica romana del 1798-99, quando Giovanni, entrato in alcune società che si erano aggiudicate le forniture per l’armata d’occupazione, mise in poco tempo da parte i capitali necessari per approfittare delle vendite dei beni nazionali, con operazioni di compravendita in cui l’elemento di successo, quello che assicurava i guadagni migliori, era dato dalla tempestività. In questo egli fu davvero insuperabile, sia per volume di affari sia per capacità di conquistare la fiducia dei conquistatori, e Renzo De Felice ha ricostruito bene il giro vorticoso dei suoi interventi su un mercato che non pareva aver segreti per lui20. Indubbia prova di sagacia non disgiunta dalla spregiudicatezza era infatti il diversificare le speculazioni in modo da ripartire gli eventuali rischi su più piani, costruire alleanze strategiche con altri imprenditori come lui abbastanza manovrieri, accorrere in soccorso di quanti – soggetti privati o istituzionali che fossero – aveva precedentemente messo in difficoltà.
Aveva cominciato con le allumiere, comprandone i 3/2021; poi aveva acquistato beni nazionali per più di 92.000 scudi22; quindi era entrato nella compagnia dei Munizionieri generali in società coi parenti della moglie e con un francese23; poi si era alleato ad un potente finanziere genovese, Domenico Lavaggi, e aveva raggranellato beni ex gesuitici per più di 36.000 scudi. Il colpo grosso lo aveva messo a segno diventando amministratore dei Munizionieri, la compagnia che aveva in appalto l’approvvigionamento di Roma e dell’armata, ed entrando con altri nobili romani (Borghese, Doria, Acquaroni) nel pool incaricato di ricevere e amministrare le contribuzioni dei cittadini24: ciò voleva dire continuo afflusso di denaro liquido e possibilità di prestare con un saggio d’interesse molto alto agli aristocratici messi in crisi dalle alte contribuzioni, ricevendone in pagamento o in pegno beni e oggetti preziosi o opere d’arte; e quando la compagnia dei Munizionieri era fallita, Torlonia, ben lungi dall’uscire di scena, con l’appoggio dei Francesi si era lanciato in nuove imprese speculative25, rischiando poco del suo e pronto ad arraffare, con avidità divenuta proverbiale, qualunque ricchezza pubblica o privata gli capitasse a portata di mano. Alla fine risulteranno acquisti di beni per un valore di 161.669 scudi26 e, nell’elenco dei maggiori patrimoni fondiari romani relativo al 1810, Torlonia si collocherà al tredicesimo posto27, avendo però davanti soltanto i grandi nomi della nobiltà cittadina; ma questa era solo una delle voci del suo bilancio complessivo. E si può ben immaginare l’antipatia concepita nei suoi confronti dagli esponenti della vecchia nobiltà, vittime di un sistema di tassazione troppo esoso per i loro mezzi (e per le loro abitudini) che, come scrive il nostro archivista, li aveva costretti a «vedersi confiscati i loro beni agricoli ed urbani e quindi assistere, impotenti, alla loro vendita al miglior offerente, giusta la fatta minaccia in caso di inadempimento dell’intimato perentorio precetto, come infatti si verificò per note famiglie che non riuscirono a procurarsi l’ammontare imposto»28: chi invece se lo procurò (e tra quelli che ricorsero al Banco ci furono anche Pio VI e Pio VII, e perfino Vittorio Emanuele i re di Sardegna)29 lo fece quasi sempre passando per Giovanni Torlonia.
Se è vero che tutto ciò ebbe luogo all’ombra della Repubblica e con il favore dei Francesi, non se ne deve dedurre che il “sor Giovanni” fosse diventato di colpo il “cittadino” Torlonia e che avesse voluto provare l’ebbrezza del giacobinismo o che fosse stato soggiogato dal fascino di Napoleone: semplicemente, egli aveva colto tutte le occasioni offertegli dai tempi calamitosi, muovendosi con estrema disinvoltura tra poteri vecchi e poteri nuovi e mantenendo sempre una chiara distinzione tra affari e politica, con una scontata predilezione per i primi rispetto alla seconda, ma anche con la percezione molto borghese della necessità di inserirsi nelle pieghe della seconda per fare andar meglio i primi. Un contemporaneo sottolineò adeguatamente non solo la sua abilità come speculatore ma anche la capacità di «conservarsi illeso in tutti i tempi, in tutte le circostanze e presso tutti i partiti»30; allo storico francese della Roma di Napoleone sembrerà assai discutibile questo prestare indifferentemente soldi a tutti, a Pio vi come alla Repubblica, ai generali del Direttorio come ai Borboni, a Pio VII come all’Impero31; quanto a Silvagni, sarebbe stato lui a osservare che per questa sua strategia, il cui fine ultimo era il raggiungimento dei titoli nobiliari, Torlonia «fu criticato, calunniato, glorificato, a seconda dei venti che spiravano, ma intanto ingrandiva, ingrandiva come un gigante»32. Questo è un punto decisivo per la conoscenza della sua personalità: se utilizziamo i parametri delineati da Norbert Elias33, Giovanni Torlonia è senza dubbio un borghese, ma un borghese che cammina spedito sulla via della nobilitazione; per cui questo «piccolo vecchio dallo sguardo inquieto, che porta un panciotto un po’ troppo lungo»34, con una moglie accorta quanto e più di lui, nelle forme tenderà a distinguersi dal suo ceto di provenienza e ad apparire sempre più aristocratico, ma nella sostanza qualcosa lo tratterrà nel suo precedente status di borghese, forse più a lungo di quanto avrebbe desiderato.
E infatti al suo tempo da molti Giovanni non era considerato altro che un «nouveau riche», «banquier de jour et duc de Bracciano la nuit» secondo la definizione della nipote di Madame Récamier35. Il marchio gli restò appiccicato addosso per molto tempo: una testimonianza di provenienza aristocratica ci racconta che un invito rivolto dai Torlonia ad un principe francese aveva «donné lieu à un sérieux débat entre les directeurs du prince. Pouvait-on aller chez un banquier?»36. Quella degli inviti era una strategia assai praticata in famiglia, soprattutto da parte della signora Torlonia che ne approfittava per creare relazioni che prima o poi avrebbero dato i loro frutti, consentendo affari ovvero procurando appoggi politici (si pensi alle molte attenzioni usate ai Bonaparte, ai Murat e al cardinale Fesch)37. Ma, pur in una società che la recente storiografia ha detto molto attenta alle forme simboliche, il denaro era sempre un buon biglietto da visita. «Gli antichi nobili – osserverà argutamente Raffaele De Cesare – non erano benevoli con la nobiltà recente, ma se questa abbondava in ricchezzze, gli scrupoli erano più facilmente superati»38. Ad ogni modo tra critiche e calunnie i titoli arrivarono, a riprova del fatto che era sempre più difficile, perfino nella Roma papale, conservare le consuetudini e le barriere sociali del passato e che a pilotare il cambiamento era, almeno in questa fase, l’aristocrazia del denaro, quella in cui spiccavano i Grazioli, gli Antonelli, i Guglielmi e appunto i Torlonia, con i loro marchesati e ducati e principati messi insieme tra il 1797 e il 1814, acquistando feudi e i relativi titoli (marchese di Romavecchia nel 1797, duca di Bracciano nel 1803 per acquisto dagli Odescalchi per 400.000 scudi, principe di Civitella Cesi nel 1813 per acquisto dai Pallavicini, duca di Poli e Guadagnolo nel 1820 per acquisto dagli Sforza Cesarini)39. Non direi di scorgere nei protagonisti di questa carriera e nei pochi altri affaristi venuti su dal nulla l’embrione di classe dirigente intravisto da Catherine Brice40, dato che in nessuno di questi speculatori di successo c’era, almeno per il momento, apparente desiderio di dirigere alcunché (e anche se ci fosse stato non sarebbe durato a lungo per la resistenza del ceto ecclesiastico a cedere il proprio potere altro che per brevi periodi); direi piuttosto che lo spirito del tempo era quello dell’individualismo e che il clima politico creato dalle innovazioni introdotte dalla prima e dalla seconda presenza dei Francesi aveva enormemente potenziato l’impatto che Giovanni Torlonia, per quanto chiacchierato, era in grado di esercitare sul panorama romano.
Che in lui qualcosa stridesse sul piano dello stile lo dimostra l’ostentazione che egli amava fare delle sue ricchezze e di ciò che esse gli avevano procurato sotto forma di palazzi, ville, opere d’arte41: Louis Madelin, lo storico della Roma di Napoleone, trova insopportabile che questo «parvenu ridicole [...] sans éducation ni façons», non più borghese ma non ancora integrato nella nobiltà malgrado sia duca di Bracciano (del 1809, lo abbiamo già ricordato, è l’iscrizione nelle tavole nobiliari del Campidoglio), passi indenne da una dominazione all’altra, accumuli nuove ricchezze sia col papa che coi suoi nemici e non si periti di portare «son habit à boutons de diamant» davanti alle autorità francesi42. Stendhal, assiduo frequentatore delle sue serate, ne ammira la capacità di trasformare tutto in oro ma allo stesso tempo ne studia la fisionomia e vi vede impresso il segno potremmo dire pre-lombrosiano della taccagneria43, anzi della «juiverie», come la chiama in una lettera all’editore della “Edinburgh Review”44. Questa caratteristica torna spesso nelle testimonianze del tempo: così Agostino Chigi racconta la lite feroce che oppose Giovanni al duca di Anguillara per il recupero di una mongolfiera francese per la quale la municipalità di Parigi avrebbe dato un misero compenso di 30 napoleoni d’oro45; ancora Stendhal raccoglie dalla bocca dello stesso Torlonia la narrazione del trucco usato – ricorrendo ad un travestimento che ne nascondeva l’identità e gli conferiva «un aspetto ancor più miserabile e giudeo del solito» – per ottenere uno sconto sull’acquisto di una partita di specchi a Parigi46. Anche Silvagni propone a più riprese l’accenno ad una presunta origine ebraica della famiglia47, ma, al di là dell’infondatezza della diceria, il fatto che essa si diffondesse tra i romani ci induce a sospettare che i Torlonia, quanto meno quelli delle prime due generazioni, non si integrassero mai a pieno nella cittadinanza: ne ottennero il rispetto, più raramente la simpatia, e non solo perché chi ha troppo danaro raramente ha anche la fortuna di riuscire simpatico ma proprio perché l’ambiente li sentiva culturalmente e spiritualmente estranei. Pur se con spirito meno acre, anche Giuseppe Gioacchino Belli metterà in risalto la loro troppo smaccata confidenza con i quattrini dicendo del figlio Alessandro che «ha sempre pronto er mijoncino in cassa»48. Indubbiamente, alle due passioni che Stendhal gli attribuisce, «per il denaro e per le arti»49, Giovanni Torlonia ne aveva aggiunta una terza, quella in cui aveva toccato livelli di vera eccellenza, l’arte di far danaro: così da trasformare in rendita anche le sue mega-feste, quelle affollate di principi e cardinali e a cui nessuno, pur sapendo che gli sarebbe costato caro, voleva mancare: il padrone di casa per magnificare le opere d’arte possedute e le furbizie con cui spesso se le era procurate, i romani per dimostrare che in società contavano qualcosa, gli stranieri per avere qualcosa di mirabolante da raccontare al ritorno in patria. Uno di questi ospiti calcolò che grazie alle commissioni bancarie pagate per farsi accreditare il danaro presso il banco «ciascuna di queste feste sontuose rende all’intelligente banchiere la somma netta e rotonda di venti mila scudi romani»50. Il risultato era che perfino gli inglesi, di cui era ben nota la spilorceria, non lasciavano Roma se prima non erano entrati in casa Torlonia; anzi vi accorrevano a frotte, tanto che una sera Chateaubriand, invitato anche lui ad un ballo, ebbe l’impressione di essere «encore ambassadeur à Londres»51.
Lo strabiliante successo del capostipite e più ancora quello dei suoi discendenti non potevano essere messi in conto a nessuna istituzione pubblica né alla condizione generale dello Stato pontificio e nemmeno al benessere del ceto sociale di appartenenza (un viaggiatore americano metteva a confronto la storia di Torlonia con lo stato di decadenza e di declino tipico della nobiltà romana del tempo)52, né erano tali da rientrare in una fase di generale crescita dell’economia proprio perché erano il successo di singole personalità. Le fortune così accumulate, investite essenzialmente nell’acquisto e nell’abbellimento di tenute e immobili urbani53, non rientravano nel contesto di una floridezza generale né stimolavano altre attività imprenditoriali ma erano collegate a fattori esterni, al punto che uno storico francese, Bertrand Gille, ha avanzato l’idea che il Banco, «primario sostegno dell’intera finanza pubblica della S. Sede oltre che prestatore a privati, fosse una specie di consociata della rete dei Rothschild»54, mentre altri hanno rilevato come non rientrasse nelle competenze del Banco quella di appoggiare lo sviluppo industriale fornendo il credito necessario55.
D’altra parte spirava soddisfazione di sé, del proprio ruolo e della propria discendenza il ritratto che Giovanni commissionava al pittore Agostino Tofanelli56. Vi era raffigurato un interno del palazzo di piazza Venezia, e la disposizione dei personaggi era studiata per dare risalto ai due genitori, ritratti in primo piano ai due lati della tavola, Giovanni, ben dritto sulla sua poltrona, a sinistra dell’osservatore, Anna Maria con la sua aria da gran dama, a destra; li univa la corona dei figli a semicerchio, Maria Luisa tra le braccia del padre, poi in ordine crescente i tre maschi, Alessandro, Carlo e Marino, infine, a sinistra della madre e in secondo piano rispetto a lei, la più grande delle figlie, Maria Teresa; non mancava l’altro segnale di distinzione, ossia l’abbigliamento assai costoso di tutti i componenti della famiglia57, grandi e piccoli; infine sullo sfondo, in una galleria chiusa verso l’alto da un soffitto a volta, compariva il vero motivo d’orgoglio e prestigio dei Torlonia, il coprotagonista del quadro, e cioè la riproduzione dell’Ercole e Lica che Giovanni aveva commissionato ad Antonio Canova nel 1801 pagandolo 18.000 scudi e che lo scultore aveva terminato nel 1815 non senza qualche contrasto con il committente al quale aveva rivolto la minaccia di una rinunzia a concludere il lavoro se non fossero state garantite una collocazione e un’illuminazione consone all’importanza dell’opera58. Da allora la gigantesca scultura fece bella mostra di sé fin quasi alla fine del secolo in una sala appositamente attrezzata del palazzo Torlonia, ex Bolognetti, di piazza Venezia: se il palazzo, secondo il sistema comunicativo delle corti d’antico regime, segnalava l’ingresso del proprietario nel rango principesco59, la scultura ne doveva sancire il ruolo dominante nel mondo della committenza e, quando possibile, del gusto; e i due elementi presi insieme alludevano in modo inequivocabile al raggiungimento di un traguardo sociale il più vicino possibile alla regalità.
Compariva così l’altra dimensione di Giovanni Torlonia, quella dell’intenditore e collezionista di opere d’arte, del munifico sostenitore finanziario dell’Accademia di San Luca (che nel 1823 gli offre quattro medaglie «fatte coniare in onore dello scultore Antonio Canova, due delle quali da consegnarsi come omaggio alla Consorte Duchessa»)60, del compratore di teatri per il piacere di sentirvi eseguita la musica di Rossini61, insomma dell’uomo quasi di cultura spuntato fuori da una costola dell’imprenditore con modalità assai simili a quelle che avevano fatto di lui il Creso di Roma62. Racconta Nicola La Marca che la raccolta era stata messa su all’inizio dell’Ottocento da Giovanni che «non potendo gareggiare con le collezioni già costituite e consolidate da secoli a Roma, si dedicò a dipinti considerati minori, quali opere di scuola fiamminga, ritratti, paesaggi che faceva acquistare dai suoi inviati in Italia e all’estero. Egli riuscì comunque ad aggiudicarsi opere importanti, sia in pubbliche aste, sia con trattative private presso varie famiglie nobili romane (i Colonna, gli Altieri, i Giustiniani, i Valenti)»63. A sua volta Liliana Barroero osserva che «quando nella momentanea interruzione dell’istituto del fidecommesso in età napoleonica diverse raccolte (quella Soderini per esempio, o i materiali dell’atelier di Bartolomeo Cavaceppi, da lui originariamente destinati all’Accademia di San Luca) vennero immessi sul mercato tramite il Banco Torlonia, in parte queste furono acquisite per arricchire le appena costruite residenze del casato»64.
Di qui, poi, il continuo ricorrere ad artisti d’ogni genere e calibro, fino a stabilire un vero e proprio rapporto di dipendenza continuata nel tempo. Un giornalista francese, Edmond About, autore di un ben noto resoconto di viaggio intitolato Rome contemporaine, noterà nel 1859 che «mentre a Parigi un principe era cliente di un avvocato, a Roma accadeva l’inverso»65. Ciò vale in qualche modo anche per Giovanni Torlonia che aveva alle sue dipendenze architetti come Giuseppe Valadier e Antonio Sarti, reclutati per risistemare e abbellire assieme ad un ricco stuolo di pittori e decoratori i palazzi e le ville che dovevano palesare all’esterno l’incessante progredire delle sue fortune. Si aprivano così, e sarebbero rimasti a lungo operativi, quelli che Fernando Mazzocca ha definito i «cantieri Torlonia»66, in un succedersi ininterrotto di committenze che se conferivano alla famiglia la più romana delle cittadinanze inserendola in una tradizione forte e rendendone credibile il gusto per l’arte classica, attivavano d’altra parte un circuito virtuoso tra abbellimento della città, offerta di nuovi punti d’attrazione per i visitatori stranieri e incremento del profilo internazionale della dinastia, facilmente spendibile anche sul piano delle collaborazioni bancarie con le ditte d’oltralpe. Non erano soldi spesi invano quelli che Giovanni Torlonia e la sua famiglia investivano nel tentativo di guadagnare in tutti i campi aperti alla loro inventiva il primato sulla scena romana, né sarebbe stato per loro concepibile un interesse che non avesse una ricaduta positiva sui tanti affari in cui erano implicati67; per cui sarebbe vano cercare nel culto del classicismo che ne orienta chiaramente le scelte quel desiderio di ribadire «l’identità universalistica» di Roma la cui riscoperta caratterizza, secondo Stefano Susinno e Liliana Barroero, il periodo compreso «tra l’età di Maratti e quella di Canova»68, e questo perché l’universalismo era concetto inaccessibile a chi aveva tanti legami d’affari con l’esterno e non era particolarmente sensibile al motivo della supremazia papale. Più che altro, mi sembra che con i suoi cantieri Torlonia volesse far passare l’idea che se i nobili di sangue suoi contemporanei (i Borghese, i Doria, i Ruspoli, i Massimo e tanti altri) brillavano della luce prodotta da ciò che era arrivato loro dal passato senza nessuna fatica, lui solo era in grado di vivere quel ruolo nel presente perché se lo era guadagnato. Direi che perfino la beneficenza e le opere di carità cui i Torlonia erano dediti sin dalla loro prima affermazione69, se anche praticate con sincero spirito cristiano, contribuivano comunque a dar loro una visibilità sociale da far valere sul piano dei rapporti d’affari con il governo papale.
Per completare il profilo di Giovanni e passare al figlio Alessandro che, pur da terzogenito, ne fu in realtà il continuatore spingendosi anzi ben oltre i suoi pur prestigiosi traguardi, occorre richiamare brevemente il suo rapporto con la discendenza. Intanto è già notevole, e lo abbiamo accennato poco fa, che nessuno dei figli, nemmeno le femmine, si sia (o sia stato) indirizzato alla vita ecclesiastica e alla prelatura. È pur vero che quello della prima metà del XIX secolo è in generale un periodo di «arretramento della nobiltà romana dalla Curia»70; ma quando mai i Torlonia vi si erano avvicinati? Tranne Carlo, si sposarono tutti, e tuttavia la strategia matrimoniale messa in atto da Giovanni, se fu accorta per le due figlie, che sposarono Maria Teresa il conte Francesco Marescotti e Maria Luisa il principe Domenico Orsini71 dopo che il padre si era molto divertito a osservare i vari principi romani che si azzuffavano per contendersele72, non funzionò altrettanto bene per i maschi, forse perché la nobiltà di sangue, tante volte da lui umiliata sul piano della ricchezza materiale, si volle prendere la soddisfazione di tenerlo alla larga, o forse perché proprio lui non volle abbassarsi a trattative di sorta con personaggi di cui aveva conosciuto le debolezze, che probabilmente disprezzava sentendosene disprezzato e che alla fin fine avrebbero tratto sicuro beneficio dal fatto di imparentarsi con lui. Fatto sta che dei suoi tre figli il primogenito, Marino, sposò Anna Sforza Cesarini, l’ereditiera dei Conti, ma contro la volontà del padre73, il secondogenito, Carlo, da giovane arruolato come il fratello maggiore nell’armata francese74, restò scapolo per tutta la vita e si diede ad opere di beneficenza che secondo l’archivista Gabrielli lo fecero morire in odore di santità75, ed è fuor di dubbio che una bella prova di santità quanto meno familiare egli la desse con le sue due donazioni ai fratelli: la prima, del 1829, a Marino (300.000 scudi più alcune tenute), la seconda, del 1833, ad Alessandro, cedendogli tutti i propri beni in cambio di un vitalizio annuo pari a 18.000 scudi76 che, morendo nel 1847, riscosse per non più di 14 anni. Quanto al terzo, Alessandro, che era nato nel 1800, sposò una Colonna, ma soltanto undici anni dopo la morte del padre (al quale peraltro aveva opposto un rifiuto quando gli aveva proposto un partito non di suo gradimento)77. Molto curata fu invece da parte di Giovanni la divisione patrimoniale che, apparentemente rispettosa della primogenitura, finì poi per creare una posizione di forza al più piccolo dei tre maschi. Infatti una decisione repentina presa poco prima di morire (1829) fece sì che fossero annullate molte delle precedenti disposizioni testamentarie; e Marino, che nel 1821 aveva ottenuto il feudo di Bracciano, il contado di Pisciarello, la tenuta di Settebagni e vari beni immobili (tra cui il palazzo di piazza Venezia, fondamentale come sede di rappresentanza), con testamento del 3 marzo 1829 perde molti dei beni ottenuti con la primogenitura e solo dopo una transazione coi fratelli sarà risarcito con 200.000 scudi, una serie di tenute e un certo numero di immobili tra i quali spicca palazzo Verospi al Corso78.
Cosa aveva fatto cambiare idea al padre inducendolo se non proprio ad annullare il privilegio del fidecommesso, ad usare un particolare riguardo al figlio minore, Alessandro, rendendolo titolare di un secondo fidecommesso certamente più rilevante sotto il profilo economico di quello del primogenito? Come ha segnalato Giovanni Montroni relativamente alle disposizioni testamentarie di Monaldo Leopardi, un fenomeno del genere era tutt’altro che raro, soprattutto in periodi di grandi trasformazioni sociali, quando cioè «il rispetto di una norma familiare», il fidecommesso appunto, doveva soggiacere «alla necessità di manipolare la regola per progettare degli equilibri più duraturi»79. Tra l’altro sembra che sin dall’inizio i tre giovani Torlonia non avessero seguito la stessa strada, il terzo essendo troppo giovane quando, come già segnalato, i primi due al tempo dell’Impero erano stati chiamati a servire nell’armata francese; e quando poi Alessandro era stato mandato più volte a Londra per studiare l’inglese lo aveva accompagnato il solo Carlo80. Come che fossero andate le cose, certamente ben prima di morire (1829) Giovanni doveva aver deciso di lasciare il titolo di principe di Civitella Cesi81 ad Alessandro, e con esso anche il Banco, «per avere riconosciuto in lui – scrive il nostro archivista – una spiccata meravigliosa attitudine per tale gestione»82. Dunque, era emersa in lui una vocazione affaristica sulla quale il padre aveva scelto di puntare molto prima di passare a miglior vita; ce ne dà la conferma un celebre brano delle Passeggiate romane, là dove Stendhal riferisce ciò che il vecchio Torlonia aveva detto durante uno dei suoi ricevimenti, giungendo a denigrare Marino («uno sciocco: ama i quadri, le arti e le statue») ed esaltando invece Alessandro, «un uomo – diceva – che conosce il valore del denaro: gli lascerò la mia banca e lui l’arricchirà, la ingrandirà, e un giorno lo vedrete non soltanto più ricco di questo o quell’altro principe, ma di tutti i principi romani messi insieme. Se arriverà ad avere la metà della mia prudenza, avrà un figlio papa»83. Ora, a parte che Marino non fu uno stupido (quanto meno nel senso tecnico del termine) e dimostrò di avere il fiuto necessario per seguire e talvolta perfino per contrastare84 il fratello in molte operazioni e per compierne altre anche molto redditizie di sua iniziativa85, la scelta di Giovanni si rivelò felicissima, anche se tra le sue varie previsioni su Alessandro una in particolare si rivelò sbagliata, quella sul figlio papa: in questo non ebbe colpa alcuna il più giovane dei suoi discendenti, che per quanto potente nulla avrebbe potuto fare per mutare il sesso delle uniche due figlie, Giovanna e Anna Maria, dategli da Teresa Colonna.
Giovanni Torlonia morì settantacinquenne il 25 febbraio 1829 e tra quelli che ne salutarono la dipartita ci fu anche Chateaubriand, che subito dopo volle riferire a Madame Récamier l’impressione che ne aveva riportato («Je l’ai vu tout peinturé sur son lit funèbre, l’épée au coté»); ma subito correggeva l’immagine troppo altera uscitagli dalla penna con un epitaffio in cui faceva capolino in modo più preciso il concetto che aveva del defunto: «Il prêtait sur gages; mais quels gages! sur des antiques, sur des tableaux renfermés pêle-mêle dans un vieux palais poudreux»86.